Dillo col teatro
Teatru



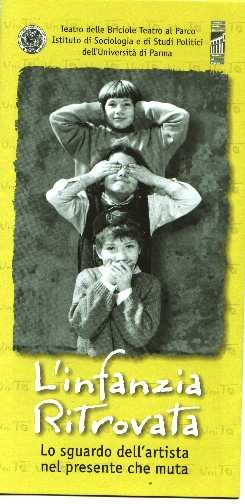



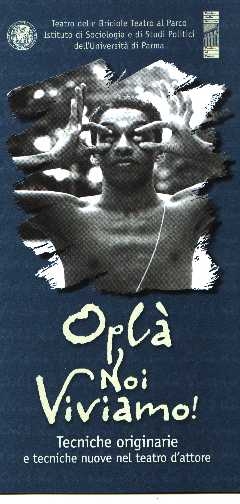
1. Tra i banchi, con la testa e senza il corpo
Nella mia infanzia, ho frequentato la scuola elementare italiana per cinque anni a partire dal 1954|55. Di quel periodo, insieme al ricordo, che il trascorrere del tempo non sembra assottigliare oltre una certa misura, conservo le “pagelle scolastiche”. Quei cinque documenti non sono identici fra di loro, ma è quello dell’anno scolastico 1955|56 che introduce una novità sulla quale intendo richiamare l’attenzione dei lettori.
Tra le altre “materie”, così erano definite le attività scolastiche sulle quali gli insegnanti assegnavano ogni trimestre il voto in decimali, compariva quell’anno “Lettura, scrittura, altre attività espressive” che dichiarava una precisa gerarchia di concetti alla quale la nostra scuola, seppure attraverso significativi cambiamenti, non sarebbe venuta meno fino ai nostri giorni.
La generica e indistinta formula “altre attività espressive” faceva seguito ai termini lettura e scrittura che indicavano in modo puntuale i fondamentali obiettivi di una scuola impegnata nel corrispondere alle esigenze di un paese nel quale l’analfabetismo, eredità della nostra storia contadina, costituiva ancora un serio problema.
Nella scuola del leggere, dello scrivere e del far di conto, così l’avremmo ricordata nei decenni successivi, gli insegnanti, che non avevano alle spalle una consolidata tradizione d’insegnamento, operavano in condizioni particolarmente difficili. Le classi erano assai numerose, ricordo scolaresche di quaranta bambini, l’edilizia insufficiente, la strumentazione assai povera.
Gli insegnanti godevano bensì di un prestigio sociale che oggi non possono vantare, e questo conferiva loro un indubbio carisma, ma erano ancora molte le famiglie poco propense a creare per i figli un clima favorevole agli studi non essendo persuase sull’utilità di mandarli a scuola. La lingua di questi bambini era il dialetto che a quei tempi, diversamente da oggi, non era considerato una nobile parlata locale da preservare, ma un vero e proprio oltraggio alla scuola e alla cultura. Il dialetto non rimandava tanto alla condizione sociale dei poveri, che erano sempre esaltati da una retorica oltremodo gonfia: diceva piuttosto di un’alterità da considerare in modo severo. Nei confronti di un’espressione dialettale, i nostri insegnanti mescolavano lo sdegno da riservare alle cose rozze e volgari, al sussiego di chi sa prendere le giuste distanze. Chi parlava in dialetto, offendeva la dignità della scuola e si opponeva al suo compito di insegnare, con una lingua comune, un sistema di valori condiviso.
In queste condizioni, insegnare a leggere, scrivere e far di conto era impresa tutt’altro che trascurabile e si può capire quale spazio la scuola riservasse alle altre “attività espressive”.
Nel mio ricordo, queste si risolvevano in qualche disegno che realizzavamo su fogli di limitate dimensioni. Usavamo la matita nera per tracciare il segno e poi riempivamo gli spazi con le matite colorate. Non ci venivano insegnati accorgimenti e tecniche particolari, per quanto ricordo, e per certo non conoscevamo l’uso né delle cere, né, tantomeno, degli acquerelli delle chine, delle tempere o di altri materiali. Immagino che tutto fosse troppo costoso sia per la scuola sia per famiglie. Ma vi è anche un altro aspetto che occorre considerare. Al di là delle matite colorate, che ognuno di noi custodiva in astucci appositi insieme alla cannuccia con qualche pennino (le “torrette” e i “gobbini” erano quelli da me preferiti, ma non disdegnavo le “manine”), alla gomma, al temperamatite e a un righello, qualsiasi altra tecnica complicava la gestione della mattinata introducendo elementi di movimento e quindi disordine rispetto all’austero assetto che la classe manteneva d’abitudine. Una tecnica di disegno che comporti per esempio l’uso di acqua, e dunque di bicchieri da riempire, svuotare, ripulire, in un ambiente di limitate dimensioni e sovraffollato può costituire un problema di ordine non indifferente. Tanto più, aspetto questo da considerare con particolare attenzione, che non eravamo bambini scolarizzati, come si direbbe oggi: molti di noi, tra i quali il sottoscritto, avevano frequentato poco o per niente una qualche scuola in preparazione delle elementari e non avevano alcuna dimestichezza con matite, penne e tantomeno con pennelli e colori per dipingere.
Considerazioni analoghe possono essere svolte per le altre non meglio definite “attività espressive”.
Non ricordo di aver mai ascoltato musica a scuola e raramente si intonava qualche canzone. A fine anno, si organizzava un saggio teatrale, una noiosa recita da proporre a genitori, nonni e, soprattutto, al direttore.
Era opinione diffusa che per ottenere buoni risultati in questi ambiti erano necessarie doti naturali che l’insegnamento e l’esercizio potevano solo surrogare. Questo cionvincimento, sono propenso a crederlo, demotivava gli insegnanti che forse consideravano le “altre attività espressive” come un capriccio della natura da prendere come tale.
Tra i miei ricordi non compare nulla che abbia le sembianze del gioco, della ginnastica o dell’educazione fisica: del resto i maestri dovevano pensare, così credo, che non avevamo affatto bisogno di esercizi supplementari a quelli che facevamo per conto nostro scorrazzando tutto il giorno nelle strade, nei cortili o nei campi. Tutto ciò che aveva a che fare col movimento, riguardava i dieci minuti dell’intervallo, che si dilatavano anche del doppio o del triplo quando gli insegnanti si fermavano a parlare tra di loro. In quei minuti, che dovevano servire per consumare la merenda, noi bambini, lasciati a noi stessi, eravamo letteralmente scatenati. La mia esperienza, o comunque il ricordo che ne conservo, è quello di intervalli trascorsi in frenetiche scorribande, in zuffe e giochi di squadra organizzati intorno a un simulacro di palla o a un fazzoletto da ghermire agli avversari. Quando l’insegnante tornava in classe, sempre indignato del nostro comportamento, sempre disposto a somministrarci una ramanzina che aveva il sapore di una litania, eravamo accaldati, stropicciati e pesti, ma avevamo fatto un pieno d’entusiasmo.
Gli insegnanti non volevano vederci in quello stato che sembrava offendere il loro ruolo e forse non si addiceva all’idea di una cultura concepita essenzialmente come fatto mentale.
Insomma la scuola aveva certo buone ragioni per limitare quanto più possibile le “altre attività espressive”; ma sono persuaso che, alla lunga, questa esclusione, per quanto motivata, come ho cercato di mostrare, da ragioni sostanziali, si sia tradotta in vera e propria ideologia, cioè in convincimento che quella non era solamente la scuola corrispondente a precise e comprensibili contingenze storiche, ma era proprio la scuola come doveva essere sulla base della sua intrinseca natura. Per farla breve, gli insegnanti dovettero persuadersi che l’ordine e la disciplina, coltivati fino alla esclusione della corporeità dal concetto di scuola, costituisse un obiettivo da perseguire tenacemente. Non si spiega diversamente il loro comportamento nei nostri confronti.
Tra i pesanti banchi di legno, quei nostri insegnanti, ammettevano fervide testoline, visini angelicati e industriose manine mentre lasciavano fuori dall’uscio corpi rumorosi e difficilmente riconducibili alla disciplina. Non potendo attuare fisicamente questa separazione, essi prescrivevano quei comportamenti che dovevano contenere, per quanto possibile, il disordinato e chiassoso movimento dei nostri corpi.
Così, a fronte di una qualche turbolenza, ci imponevano di tenere le “mani in seconda”, allacciate dietro la schiena secondo una modalità che corrispondeva alla immobilizzazione praticata dai poliziotti attraverso le manette.
Ristabilito l'ordine, il comando “braccia conserte” corrispondeva allo stato di riposo che il sergente consente alla truppa; ma nel fasciarsi intorno al corpo, le nostre braccia simulavano anche la posizione che assumevano i malati mentali cui veniva imposta la camicia di forza.
Quando poi si doveva abbassare il capo tra le braccia per il sonnellino, il bambino assumeva le sembianze del devoto fedele che, difronte al rito sacro, si rinchiude in sé stesso per donarsi alla divinità.
In queste pratiche quotidiane, senza voler richiamare esempi di minacce e castighi che la memoria collettiva ha tradotto in luoghi comuni, la scuola dimostrava di concepire la corporeità come una forza ribelle da controllare, domare, irretire e comunque non certo da liberare.
Potremmo spiegare tutto questo ricordando i debiti vistosi contratti nei tempi dalla nostra cultura nei confronti del corpo. Dovremo risalire al cartesianesimo per sottolineare, una volta ancora, la responsabilità della filosofia del cogito? O dovremo tirare in ballo il cristianesimo e la sua censura del corpo? Torneremo a Platone e al mito della biga alata dalla quale l’anima concupiscente precipita nel corpo concepito come carcere? O dovremo ricordare la lezione degli esistenzialisti che ci mostrarono come il nostro stesso linguaggio riveli un atteggiamento ambivalente nei confronti del corpo col quale dichiariamo un rapporto di possesso (“ho un corpo”, “ho un forte mal di testa”, siamo soliti dire) mentre riserviamo un più pregnante rapporto di identificazione con la persona, con le attitudini intellettuali o comunque con le qualità degli individui (“sono una persona”, “è un genio”, “ è un’anima persa”, “è alto, è grasso”)?
2. Con la penna nella mano sbagliata
Questo percorso è noto e per parte mia, nei limiti di questa riflessione, preferisco seguire un’altra strada.
Certo l’ideologia trova la sua compiuta formalizzazione nei grandi sistemi di pensiero, ma quotidianamente si nutre degli atti con i quali condividiamo percorsi che sembrano al riparo da interpretazioni divergenti sulla base di assunti rigorosi, atti che insomma ci sembrano così universalmente giusti da poterli considerare naturali.
Nella mia scuola elementare, l’atteggiamento nei confronti della corporeità fondava su convinzioni largamente condivise dall’opinione pubblica. Vorrei qui offrirne un saggio, in forma oltremodo schematica, muovendo ancora dall’osservatorio della mia personale esperienza.
Dirò anzitutto che sono un mancino e che negli anni in cui ho frequentato la scuola elementare non era consentito scrivere né disegnare con la mano sinistra.
Ho accennato più sopra, non casualmente, ai nostri astucci e ho detto che contenevano tra l’altro cannucce e pennini. E’ possibile descrivere la sofferenza di un bambino che, mancino dalla nascita, deve scrivere, con la mano destra, delle parole e delle frasi in spazi circoscritti usando una cannuccia e un pennino da intingere in un calamaio? Si può immaginare l’umiliazione di scrivere la letterina al Bambino Gesù perché porti i doni di Natale e allagarla di macchie, riempirla di errori d’ortografia e di cancellature? E più tardi, che cosa sono stati per me i dettati, l’esercizio quotidiano di scrivere un testo sotto dettatura per imparare l’ortografia, quando non avevo che due possibilità: o concentrarmi per migliorare l’ordine e la grafia, ma riempiendo quasi ogni parola di errori, o scrivere in modo corretto, ma così disordinato da risultare illeggibile?
Quando poi l’insegnante ci faceva disegnare, era per me sconfortante confrontare i miei segni pesanti e tremuli con le figure precise e ordinate di molti altri bambini. Se poi passavo al colore, non riuscivo mai a restare nei margini delle misere figure da me tracciate. Mi ero abituato a disegnare il busto di uno scudiero con un elmo in testa e un’armatura che gli copriva tutto il corpo. Ripetevo sempre quei modesti segni che mi erano divenuti in qualche modo familiari e che il maestro accettava senza degnarli d’uno sguardo. Gli altri bambini erano virtuosi nel disegno e nell’uso del colore; le mie angosce cominciavano quando, ancor prima di tracciare un segno, mettevo mano al temperino per appuntire la matita. Anche per questo esercizio dovevo usare la destra e il risultato era che le punte si spezzavano, le matite diventavano dei mozziconi e io dovevo rassegnarmi a un modesto risultato. Invidiavo le matite lunghe e appuntite dei miei compagni e ne chiedevo spesso di nuove ai miei genitori che erano generosi nell’assecondarmi cercando sempre i prodotti migliori. Ma era una lotta impari: la mia mano destra era troppo pesante e quando potevo disporre di una matita nuova e affilata in modo impeccabile, la punta si spezzava assai presto sotto il suo peso.
Ora non si deve credere ch’io mi sia imbattuto in insegnanti particolarmente ottusi: il loro comportamento nei confronti dei mancini era generalmente condiviso. Anche in famiglia, genitori e zii, di cui escludo vocazioni di tipo autoritario, consideravano normale insegnarmi a mangiare e a compiere attività manuale usando la destra.
Non vi era dunque una qualche forma di contestazione a questa pratica alla quale né mi ribellavo, né cercavo di sottrarmi al di là delle mie spontanee inclinazioni.
La conseguenza ch’io giudico più sorprendente di tutto ciò, consiste nel fatto che non vi era né un luogo, né un momento in cui io cercassi di barare. Se lo avessi fatto avrei potuto costatare quali risultati avrei ottenuto, nel disegno e nella scrittura, usando la sinistra e avrei potuto stabilire così un altro tipo di confronto con i miei compagni di scuola: sarebbe stato, finalmente, un confronto alla pari.
Questa idea, neppure questa idea, si è mai insinuata in me. Non ho mai saputo che cosa avrei potuto disegnare usando la matita con la sinistra! Questo mi sembra oggi stupefacente. Né a me, né ai miei genitori, né a qualche amico o conoscente è mai venuta l’idea di suggerirmi: “Prova a usare la tua mano, per scherzo”. Quale disegno avrei realizzato se avessi concepito questo inganno? Quanti sono gli espedienti che un bambino, un adolescente, un ragazzo, escogitano per migliorare il loro rendimento scolastico? E quanti sono gli alleati, anche tra gli adulti, che trova in questa ricerca? E se dalla mia mancina fosse uscito fuori un bel disegno, una cosa decorosa, dico, come mi sarei comportato in seguito? E, soprattutto, avrei forse pensato di me stesso che certo non ero bravo nel disegno, usando la destra, ma che sarebbe stata tutt’altra cosa se avessi potuto usare la sinistra?
Di fatto non ho mai neppure pensato di usare la mia mano migliore per scrivere, meglio e più in fretta, neppure i compiti di casa, neppure un biglietto personale da mandare a qualcuno. Questo inganno non si è mai formalizzato nella mia mente e io non saprò mai che cosa avrei potuto disegnare al posto di quell’improponibile guerriero.
Accettavo in questo modo l’idea stessa che per disegnare e dipingere occorre il talento naturale e ritenevo di esserne privo.
Non posso dire che così sia anche per gli altri mancini indotti come me a usare la destra, che anche loro, di norma, non abbiano provato a barare, non abbiano mai saputo quali disegni avrebbero potuto realizzare con la sinistra. Non mi sono mai occupato di questa materia, sulla quale scrivo qui per la prima volta, né mi interessa rifarmi alla letteratura esistente, che immagino copiosa e che non conosco; queste riflessioni dovrebbero essere sufficienti, nelle mie intenzioni, per evidenziare l’atteggiamento di generale estraneità della scuola nei confronti della corporeità.
Lo rivela in un modo che a me sembra emblematico l’atteggiamento nei confronti del concetto di handicap.
Al di là dei ritardi con i quali il problema è stato affrontato, è opportuno ricordare che a fatica la scuola ha introdotto nel suo lessico l’espressione portatore di handicap in luogo di handicappato. Ancor oggi mi capita spesso di dover precisare che non si è trattato di un superficiale cambiamento di parole, ma di un’acquisizione concettuale dalla notevole importanza. Con la parola handicappato si confonde il tutto con la parte, si estende il difetto alla persona. Nell’espressione portatore d’handicap il problema viene circoscritto a una definita forma di inabilità. Inoltre in questa accezione non si esclude la possibilità di cambiamento che è invece negata nell’altra. Un ulteriore guadagno concettuale è costituito dall’espressione disabile con la quale non ci si riferisce direttamente alla persona, ma a una sua disposizione nell’affrontare definite situazioni. Rispetto a questa espressione, tuttavia, è preferibile la locuzione portatore di altre abilità. Mi chiedo infatti come si possa considerare disabile una persona che completi gli studi, o comunque compia importanti percorsi di apprendimento, avendo gravi menomazioni. Devo presumere che attinga a risorse e abilità generalmente sconosciute e inutilizzate.
Nella quotidianità, a scuola come nelle altre relazioni sociali, il corpo del mancino e del portatore di altre abilità è per noi tutti un mistero nel senso che il suo linguaggio ci risulta estraneo perché anzitutto non abbiamo alcuna dimestichezza col linguaggio del nostro stesso corpo.
Quasi tutti gli oggetti di uso comune, a partire da quelli della cucina, sono così concepiti da mettere in obiettiva difficoltà un mancino. Il più delle volte sarebbero sufficienti accorgimenti assolutamente elementari per evitargli ogni difficoltà, ma non vengono introdotti: in questo senso non ho visto alcun progresso col trascorrere degli anni: è sempre il mancino che deve adattare i propri movimenti agli oggetti che non sono stati concepiti per lui.
Anche nel relazionarsi agli altri e nella stessa vita sessuale il mancino ha caratteristiche proprie. Il modo di abbracciare, baciare, accarezzare, proteggere e anche di aggredire comporta modificazioni relazionali di cui spesso le persone hanno una percezione fugace e sulla quale non si soffermano a riflettere. Nella relazione, il mancino offre un altro lato del corpo e introduce un patteggiamento che di norma si risolve in modo istantaneo.
Deve essere chiaro che non mi propongo di sottolineare la situazione di disagio del mancino, né intendo esprimere l’ennesimo lamento nei confronti dell’umana incomprensione.
E’ un altro tipo di riflessione che sto seguendo: molte cose ch’io so del mio corpo e di quello degli altri dipende dalla consuetudine di vivere in un modo di oggetti e relazioni che non sono stati concepiti per me in quanto mancino. Questa condizione mi permette anche di vedere come tutti gli altri, in quanto destrimani, non abbiano un’analoga consapevolezza della loro corporeità. Per loro è scontato che tutto sia a portata di mano. Non devono organizzare una particolare strategia per affrontare situazioni banali. La consequenza è che, diversamente da me, non hanno consapevolezza della loro e della mia condizione. Tantomeno riflettono sul come sono stati concepiti gli oggetti e a quali destinatari sono stati riservati.
Alla mia età, la mia condizione non mi provoca particolari disagi. Non mi definisco un ambidestro, dal momento che non faccio le stesse cose indifferentemente con la mano destra o con la sinistra, ma talune con la destra e altre con la sinistra: in ogni caso so destreggiarmi in modo accettabile. Quanto ai piedi, che non servono solo per dar calci, come credono i più, la mia originaria condizione non è stata contaminata. Non saprò mai se e quali danni ho subito in quanto mancino contrastato e, non sapendolo, posso mettere nel conto di aver tratto anche qualche profitto dagli ostacoli che mi sono stati imposti: chi può dire che non abbiano esaltato capacità che altrimenti sarebbero rimaste nascoste? Ma aldilà del mio caso, dei casi simili al mio, dei casi di chi è portatore d’altre abilità, resta il fatto che la nostra cultura, e la nostra scuola rimane sostanzialmente estranea a un confronto con la corporeità.
3. Che tutto cambi perché nulla cambi
Si potrà obiettare che e così è stato in passato, le cose stanno oggi ben diversamente. Chi non vede come fioriscano ovunque attività destinate proprio alla cura del corpo e a un rapporto di maggiore consapevolezza con esso? E non è forse vero che la scuola dedica sempre maggiore attenzione alle attività che ne esaltano l’espressività? Qualcuno potrebbe negare che proprio la scuola in generale e soprattutto quella che accompagna il bambino nei primi anni di vita è un fertile laboratorio di movimento, manualità e creatività?
Le cose stanno così, ma nella scuola il primato del sapere letterario, del parlar bene e dello scrivere ornato è ancora solido e, nonostante tutto, fa l’occhiolino alla scuola del passato.
Anzitutto occorre riconoscere il primato dei letterati nella scuola: la loro formazione, la loro dominante presenza nella classe, il comune riconoscimento di colleghi, studenti e genitori li rende veri e propri chierici della scuola di ogni ordine e grado.
In secondo luogo persiste, nei docenti e nell’opinione pubblica, l’identificazione della scuola con l’apprendimento e l’uso corretto della lingua. In un qualsiasi salotto un errore grammaticale è stigmatizzato mentre l’ignoranza di una elementare conoscenza scientifica o tecnica non solo è tollerata, ma alimenta un certo snobbismo quasi dovessimo ostentarla e andarne fieri. Nella scuola, uno studente che parli in modo disinvolto si avvantaggia di questa dote assai più di uno studente che sappia suonare, danzare, cantare o dipingere. Il contesto espressivo nel quale viene esercitata la stessa comunicazione verbale, come ho scritto altrove, è accuratamente delimitato dalla scuola. Le capacità che vengono apprezzate sono propriamente quelle che consentono l’esposizione anodina d’un tracciato garantito da una ben individuabile razionalità scientifica o, se si preferisce, disciplinare.
La capacità di esprimersi correttamente solo attraverso la danza, la musica, il disegno o la recitazione, non viene generalmente assunta come un indizio oltremodo significativo di doti realmente esistenti, ma represse. L’insegnante e i genitori, difronte a un ragazzo che sappia recitare bene, ma che pervicacemente ritardi l’apprendimento delle materie curricolari, sono portati a esprimere giudizi severi sulla sua maturità. I suoi successi sul palcoscenico o in altre attività espressive non canoniche li confermano nel giudizio che è uno scavezzacollo e che non si applica se non nelle cose divertenti. L’idea che la recita, stabilendo una relazione tra parola, gesto, spazio, altri attori, e pubblico consenta di rimuovere blocchi emotivi forse provocati dalla cesura forzata tra mente e corpo realizzata dai procedimenti esclusivamente raziocinanti delle discipline curricolari, in molti casi non sembra sfiorare gli insegnanti. Sul piano scolastico, il linguaggio del corpo è tenuto in scarsissimo conto e di norma non è assunto come un indizio probante per rivedere un giudizio sul ragazzo assunto nelle altre prove. Con ciò le discipline che più fanno riferimento a questo tipo di linguaggio, vengono declassate a un ruolo subalterno e, nell’opinione del giovane, si conferma l’idea che l’intelligenza delle persone si misuri anzitutto sulla loro capacità di usare la sintassi e costrutti letterari evoluti.
Credo insomma che la nostra scuola continui a essere quella del leggere scrivere e far di conto, che al di là delle apparenze essa non abbia modificato questa antica vocazione. Mi rendo conto che questa affermazione può sembrare infondata a fronte delle innovazioni introdotte, dallo spazio ingente di sperimentazione destinato alla libera creatività. Altri potrebbero considerare il mio giudizio provocatorio e avrebbero ottime ragioni di preoccuparsi pensando all’eventualità che la scuola venga sempre più concepita come un laboratorio teatrale o come un atelier di pittura.
A ben vedere, la scuola non si modifica sostanzialmente se concepisce il proprio aggiornamento come conoscenza di nuovi linguaggi, ma quando sia in grado di assumere nuovi linguaggi all’interno della propria concezione e dei procedimenti che le sono tipici.
Prendiamo come esempio il linguaggio teatrale.
E’ utile introdurlo nell’esperienza scolastica? Molte scuole italiane di ogni ordine e grado sembrano crederlo a giudicare dallo spazio che gli dedicano.
Di fatto nelle scuole di ogni ordine e grado si realizzano spettacoli teatrali avvalendosi, in alcuni casi, di competenze professionali specifiche (drammaturghi, registi o attori), in altri casi attingendo a risorse interne (docenti con una loro personale cultura teatrale certificata in molti casi dalla partecipazione a corsi di formazione o di specializzazione). Questa pratica, che non saprei quantificare, può dirsi acquisita.
E’ una consuetudine è da incoraggiare? Certamente sì, a mio giudizio.
Introduce autentiche modificazioni nella scuola? Certamente no, a mio giudizio.
E’ sicuramente importante che gli studenti, a qualsiasi età, conoscano un testo teatrale classico e lavorino alla sua messinscena. E’ altresì auspicabile che imparino a comporre testi teatrali: tutto ciò che può ampliare le loro conoscenze in ambito artistico, tutto ciò che consente esplorazioni e arricchimenti di tipo creativo non è forse benvenuto? Ma in questo senso la conoscenza del linguaggio teatrale andrebbe incoraggiata come la conoscenza di qualsiasi altro linguaggio artistico.
Per altro verso, si potrebbe legittimamente sostenere che, nella nostra società, vi è un bisogno particolare di sperimentare il linguaggio teatrale nei percorsi educativi per favorire, in modo specifico, i processi di socializzazione.
Nella nostra epoca infatti la grande dimensione delle città e la loro configurazione, il modo di vivere gli spazi e i tempi comuni segue logiche e modalità assai diverse da un recente passato. Giudicherei affrettato concludere che le spinte disgregative e anomiche siano oggi particolarmente allarmanti, ma è certamente vero che i processi di socializzazione sperimentano percorsi affatto nuovi rispetto a un passato anche recente. Basti pensare come i luoghi della comunicazione tra le diverse generazioni si siano modificati nel volgere di pochi decenni. Chi era bambino negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, la generazione degli attuali nonni, condivideva con gli adulti la cucina, la stalla, la bottega, la piazza in modi che erano depositati da una lunga tradizione. Oggi, le diverse generazioni, hanno altri luoghi, tempi e modi di incontrarsi e di comunicare.
Quando una forma consolidata di relazione sociale scompare, la tendenza più diffusa è quella di guardare, con diversi sentimenti, alla sua mancanza. Viceversa, il compito di chi analizza le modificazioni sociali, mentre si interroga sulle ragioni di un declino, è piuttosto quello di indirizzare la sua attenzione a ciò che si viene formando in luogo della relazione scomparsa. Così, nella nostra società, possono affermare che manchino forme di socializzazione solo quanti, analizzando il presente, abbiano nelle loro teste escusivamente il modello del passato e a esso non siano in grado di sottrarsi.
Per chi non si lasci irretire da questo schema, la lettura di relazioni sociali in via di formazione costituisce un lavoro, oltremodo difficile e particolannente esposto a possibili smentite, ma inelusibile ove si muova dall'assunto che non sono concepibili relazioni sociali senza corrispondenti modalità comunicative. Con questo, l'analista non si rassegna necessariamente a giustificare una qualsiasi forma di comunicazione. Nella conclusione che, comunque, i gruppi sociali danno vita a forme originali di relazioni, non è necessariamente implicito un giudizio di tipo consolatorio. Al contrario, nel cogliere e denominare le modalità con cui in un contesto dato gli individui vengono promuovendo la loro socialità, l'analista consegna un materiale vivo di riflessione e sperimentazione mentre chi si limita a denunciare un vuoto, una mancanza, nega di fatto l'esistenza di individui in carne e ossa e il loro modo originale di esprimersi rimanendo in estatica contemplazione del passato.
La pratica teatrale è un fecondo laboratorio nel quale interpretare e favorire forme nuove di socializzazione. L’azione teatrale, in quanto simulazione, mette sotto vetro la relazione degli attori e la rivela nella sua diversità rispetto alle relazioni quotidiane. Queste ultime sono opache, illeggibili, perché appunto la nostra tendenza è quella di collocarle in un contesto che non è il loro. Il teatro funge da lente d’ingrandimento, le rende esorbitanti rispetto alla loro stessa dimensione aiutandoci a comprendere percorsi che abitualmente ci sfuggono. Non si deve credere che ciò avvenga soltanto quando si metta in scena un testo nel quale si fa riferimento a situazioni del nostro presente. Non è tanto il contenuto a essere rivelatore, quanto il modo di affrontarlo. Il teatro esprime tendenzialmente nuove forme di socializzazione nel modo col quale i suoi protagonisti si relazionano per mettere in scena un testo, fosse anche un classico. E queste nuove forme di socializzazione si rivelano anzitutto, non importa a quale livello di consapevolezza, ai protagonisti della messinscena.
Tutto questo è particolarmente evidente nell’educazione interculturale.
Non solo il teatro veicola i contenuti di civiltà diverse, ciò che può fare qualsiasi altro linguaggio artistico, ma ne consente un’interna lettura da parte dei suoi protagonisti. Negli ultimi anni, si è autorevolmente sottolineato che l'educazione interculturale dovrà sempre più costituire un modo di pensare le relazioni educative in quanto tali e non un servizio a fronte di necessità particolari. Non si tratta insomma di corrispondere soltanto ai bisogni di allievi che provengono da diversi paesi, ma di pensare e prospettare la cultura come espressione dei modi con i quali nei più diversi contesti gli individui costruiscono la loro storia. Il teatro consente di praticare dall'interno i linguaggi più lontani dalla nostra personale esperienza di guadagnare una consapevolezza che attraversa la nostra persona e non si limita al piano dell'acquisizione mentale.
A scuola, l’esperienza teatrale è inoltre uno strumento che credo si dovrebbe considerare senza uguali per educare negli allievi la consapevolezza del sé come entità psicosomatica.
Mi sono a lungo soffermato sul fatto che, tradizionalmente, la scuola tende a disgiungere la mente dal corpo. Nell'esperienza teatrale, il rapporto della parola col gesto, il movimento del corpo in relazione allo spazio e al corpo degli altri attori, dicono di una relazione intersoggettiva che merita di essere incoraggiata soprattutto in un periodo come questo caratteràzato dall'invadenza di linguaggi interattivi che mettono noi tutti in continua relazione con uno schermo, un congegno, una macchina. A dire il vero, l'abitudine a pensare col corpo che si muove in armonia con altri corpi non è estranea alle società che si sono venute sviluppando nel segno dell'informatica. Ogni metropoli moderna mette in scena quotidianamente lo spettacolo di moltitudini che si destreggiano in spazi limitati quasi corrispondessero alle direttive di un regista davvero straordinario. Nel traffico convulso della città, esercitiamo abilità che dicono di come si sia venuta costruendo una particolare forma di sintonia del nostro essere psicosomatico con l'ambiente nel quale viviamo. Questa condizione non va ignorata e neppure sottovalutata dal momento che costituisce, soprattutto per le giovani generazioni, un modo d'essere acquisito; ma neppure possiamo rassegnarci all'idea che sia il traffico urbano a metterci alla prova e a definire la nostra vitalità psicosomatica per il resto alquanto avvilita dall'invadenza della comunicazione digitale. Psicologi e psicanalisti ricorrono sempre più spesso a esperienze confinanti con la pratica teatrale per curare i loro pazienti; che la scuola prenda in seria considerazione le ragioni del corpo nei processi dell'apprendimento e per farlo valorizzi percorsi di tipo drammaturgico è senz'altro auspicabile.
Per queste ragioni, che meriterebbero di essere approfondite assai più di quanto non mi sia possibile fare in questa sede, non dubito che l’esperienza teatrale sia di grande utilità nella scuola e nelle relazioni educative.
In questo modo, tuttavia, occorre averne piena consapevolezza, l’incontro col teatro costituisce un’acquisizione dall’esterno che non modifica la scuola nei suoi lineamenti essenziali, semplicemente li arricchisce di una particolare esperienza.
4. Il teatro e la scuola: un confronto di linguaggi
La scuola intraprende un diverso percorso quando si proponga di mutuare il linguaggio teatrale all’interno dei percorsi che le sono propri. E’ quanto da anni sperimentiamo a Parma nell’associazione culturale Da zero all’infinito e nell’ambito del progetto Unitea una sigla che indica la collaborazione fra il mio insegnamento di Sociologia dell’educazione all’università e il locale Teatro al Parco.
Nei nostri lavori, abbiamo definito lezione spettacolo un percorso didattico, in cui un contenuto è proposto attraverso modalità e linguaggi drammaturgici.
La lezione spettacolo può essere proposta anche al di fuori del contesto scolastico, per esempio indirizzandola a un pubblico di formatori: quando ciò accada, essa è utilizzata soprattutto per l’aspetto della divulgazione scientifica. La forma drammaturgica consente di veicolare contenuti settoriali anche in un pubblico di non specialisti. In questa sede, mi limito a considerare le applicazioni della lezione spettacolo nell’ambito della scuola. Per quanto non vi siano limitazioni al suo impiego, essendo realizzabile anche alle elementari e perfino nelle esperienze scolastiche precedenti, userò per semplificare i termini “lezione” e “studenti” che abitualmente rinviano alle scuole superiori.
A scuola la lezione spettacolo è realizzata da insegnanti e studenti che, con una precisa distinzione di ruoli lavorano al medesimo progetto di ricerca. E’ appunto la ricerca il tratto caratteristico che la lezione spettacolo assume quando venga impiegata nell’ambito della scuola.
Lo slogan “Dillo col teatro”, per quanto possano valere le forme semplificate, indica l’obiettivo della lezione spettacolo nella scuola. Questo tipo di intervento elabora infatti percorsi propri per esporre contenuti di discipline diverse. Attraverso intersezioni disciplinari che si compongono in modalità drammaturgiche, si mira a dire col teatro ciò che abitualmente la scuola esprime con i linguaggi settoriali. E’ evidente che, “dicendolo col teatro”, e quindi attraverso un linguaggio diverso da quello disciplinare, il contenuto non rimane inalterato. Ma l’obiettivo non è certo quello di ribadire il medesimo concetto, bensì di cogliere la ricchezza e le molteplici suggestioni che esso ci suggerisce affrontandolo in modi diversi. La lezione spettacolo è dunque un modo di attraversare i contenuti della ricerca con linguaggi diversificati.
Tipica della lezione - spettacolo è la modalità intersoggettiva, che appartiene alla relazione teatrale.
Nondimeno la lezione spettacolo fa ampiamente uso dei linguaggi multimediali sia nella sua preparazione, sia nel suo esito. Essa è originariamente concepita come un ipertesto ovvero come un contenitore espandibile tendenzialmente senza limiti nel quale possono essere raccolti e sistemati contenuti diversi. Nel suo esito poi, l’utilizzo di linguaggi mediali (slide, diapositive, filmati), si interseca con le parti che prevedono la presenza in scena degli attori.
Durante la lezione - spettacolo, che ha mediamente la durata di 120 minuti, si articolano quattro modalità espressive.
La tradizionale lezione frontale
E’ il momento di raccordo tra le diverse parti della lezione e ne costituisce il filo conduttore. Procede per concetti e ha l’obiettivo di dimostrare le tesi proposte. E’ propriamente la parte in cui operano gli insegnanti. In sede di preparazione della lezione, costituisce il tracciato principale da cui si dipartono e a cui vanno ricondotti gli altri momenti. Nella realizzazione della lezione è il tessuto connettivo reso evidente dall’insegnante che funge da vero e proprio regista in campo. E’ senz’altro possibile che questa funzione sia svolta da più insegnanti.
2. La scheda di documentazione
Tiene il posto che nella lezione frontale è della citazione. Di questa è più ampia e esaustiva. La scheda di documentazione viene letta da uno o più studenti - ricercatori. A seconda dei casi può essere illustrata con diapositive, grafici o filmati. Ha una durata media di tre minuti e spesso si conclude con una slide che ne riassume il contenuto.
3. La scheda di documentazione drammatizzata
Ha caratteristiche analoghe alla precedente, ma viene liberamente rielaborata introducendo di volta in volta suoni, musiche, immagini, e in generale una seppur elementare scenografia. In alcuni casi le schede drammatizzate consistono in sintetici scambi di opinioni fra autori, a volte di epoche e tradizioni distanti, portati in scena dagli studenti - ricercatori. Mediamente le schede di documentazione drammatizzata hanno una durata superiore a quelle precedenti, intorno ai cinque minuti.
4. Atopie teatrali
Sono, appunto, non luoghi teatrali nel senso che non raggiungono una compiuta forma teatrale pur avendone alcuni aspetti. Le atopie teatrali sono il momento di ridondanza della lezione spettacolo, una sorta di metafora del lavoro compiuto. I più rilevanti nodi problematici, proposti attraverso discipline e linguaggi diversi, ma pur sempre nella forma dell’approccio argomentativo e infine dimostrativo, sono ora ribaditi con la modalità evocativa della messinscena. A volte le atopie sono liberi adattamenti di testi esistenti, più spesso sono prodotti originali derivati dai contenuti della lezione - spettacolo. L’incompiutezza, dal punto di vista teatrale, dell’atopia, il suo essere un’assenza di luogo teatrale consiste: nel fatto di non essere un prodotto dotato di una propria autonomia, ma di essere uno spot teatrale la cui funzione è di ribadire il contenuto della lezione e il cui significato è di conseguenza comprensibile nel contesto della lezione spettacolo
nel luogo (l’aula scolastica) in cui si svolge la messinscena
nella scenografia, assolutamente povera e limitata all’uso di oggetti, o loro simboli, indispensabili per la comprensione del testo
nella recitazione (a cura degli studenti - ricercatori e degli insegnanti) realizzata leggendo il copione che viene dichiaratamente ostentato sulla scena.
Nell’ambito della scuola, la lezione spettacolo non sostituisce, occorre dirlo?, ogni tipo di lezione, ma è un momento di lavoro, preferibilmente interdisciplinare, che interviene nella programmazione ordinaria.
Il pubblico, indispensabile a teatro, lo è un po’ meno nella lezione spettacolo che certo può essere proposta all’interno della scuola e non si esclude anche al suo esterno come “saggio” di ciò che sa realizzare: essa è comunque, fondamentalmente un momento del lavoro scolastico, un modo per mettere noi stessi, docenti e studenti, fisicamente alla prove dei linguaggi che di solito attraversiamo solo mentalmente. Lo studiare, il ricercare, l’apprendere sono concepiti a partire dall’esperienza del nostro essere corporeo. La scuola, abitualmente, esercita gli studenti a riproporre ciò che hanno appreso in una forma che non è la propria, ma quella altrui, quella dei programmi, della tradizione, degli insegnanti. Essi vengono valutati per come si adeguano a ciò che è stato proposto e per come lo ripetono. Con la lezione spettacolo viene dilatato lo spazio della ricerca assegnando allo studente il compito di portare contributi che consentano di realizzare la comune lezione (e non soltanto un approfondimento a uso personale). Inoltre, gli studenti iscrivono il loro lavoro in una messinscena concepita collegialmente. Questo aspetto deve essere considerato con particolare attenzione. L’oggetto della ricerca non va isolato e proposto individualmente attraverso l’esposizione orale o scritta, ma viene iscritto in un più generale discorso che ha una propria forma originale. Il modo di esprimersi del singolo studente ricercatore deve misurarsi con questa modalità espressiva costruita da molte persone (gli altri studenti ricercatori, gli insegnanti, forse esperti di settore chiamati dalla scuola per elaborare il contenuto o per contribuire alla messinscena). In altre parole, il sapere acquisito con lo studio, non è più un fatto privato o, meglio, un linguaggio da scambiare con l’insegnante: è invece il segmento di un fatto comunicativo costruito con soggetti diversi.
Ogni scuola e ogni classe può adattare la lezione spettacolo alle proprie esigenze, come è ovvio.
Ma aldilà delle soluzioni tecniche, che sono un compito cui devono attendere gli insegnanti, mi preme ribadire in conclusione il concetto che con la lezione spettacolo la scuola mutua il linguaggio teatrale all’interno dei propri procedimenti. L’esperienza teatrale non è più soltanto un’acquisizione dall’esterno che arricchisce il patrimonio della scuola, non è un’altra, generica attività espressiva cui ricorrere per assecondare la moda, ma costituisce un linguaggio originale nell’ordinario lavoro dell’insegnamento.
